Capodanno è il normale proliferare di bilanci e buoni propositi, il momento cadenzato da un calendario, da un orario, in cui con calma ci accingiamo ad aprire il guardaroba degli accadimenti e scegliere l’abito migliore da indossare per uno dei nostri appuntamenti più importanti, quello con i ricordi.
Piccoli o grandi, uomini o donne, rappezzati o già in frantumi, a capodanno prendiamo coraggio e ci avviciniamo al ricordo in maniera convenzionalmente più giustificata, quando invece piangere o ridere all’angolo di una strada, in un momento in cui riaffiora la bolla di tutto quello che abbiamo sottaciuto al nostro raziocinio, è più umano, e quindi oggi, sempre convenzionalmente, meno giustificabile.
Al mio appuntamento ci sono adesso. In ritardo. Irrequieto ed ansante. Con il labbro rotto dal morso della tensione ed alcune gocce che macchiano il mio vestito. Tracce di sangue, oppure lacrime, forse di gioia, forse di dolore, forse no so, forse tutte queste cose assieme. Dovrei essere sereno e tranquillo, dovrei, invece guardo esitante l’abito che indosso, da sopra a sotto. E’ vecchio, fuori misura, strappato e sporcato da pezzi di realtà che fatico ancora ad accettare, rifinito però di particolari che mi aiutano a ricordare da che parte sia il cuore. Era un abito di alta manifattura, oggi molto meno, messo troppo tempo fuori ad asciugare accanto alle mie vergogne. Rimane comunque all’altezza del ritrovo degli eccessi dove mi sto dirigendo, quello in cui gli invitati mi riporteranno a gioie esuberanti e dolori profondissimi. Aggiusto le maniche, prima destra, poi sinistra, allargo con un dito il nodo alla cravatta, prendo tempo. Sospiro, chiudo gli occhi e provo ad ascoltare la sensazione che sto provando…
Saudade è una parola svelatami dai portoghesi. La vera e propria traduzione in altra lingua non esiste, è una parola che ti insegnano a sentirla più che a tradurla. E’ una fluttuazione, un insieme di emozioni vissute in solitudine dai portoghesi quando salpavano dai porti lusitani in rotta verso il Brasile. Era il pensiero di ciò che lasciavano, il ricordo che procurava in loro un sorriso o viceversa una lacrima, era il desiderio che li aveva spinti su quella nave, erano i sogni riposti al di là dell’oceano. Il suono che fai per produrla ti accompagna nell’oscillazione degli stati d’animo che essa racchiude, la sua pronuncia accarezza tutte le parole che in italiano si utilizzano per significarla, ossia solitudine, desiderio, mancanza e nostalgia per ciò che hai perduto e per ciò che perderai; “l’amore che rimane” la chiamano anche, quello a cui dedichi un sospiro con gli occhi rivolti all’insù, quello che ti riga le guance stretto nella tua intimità.

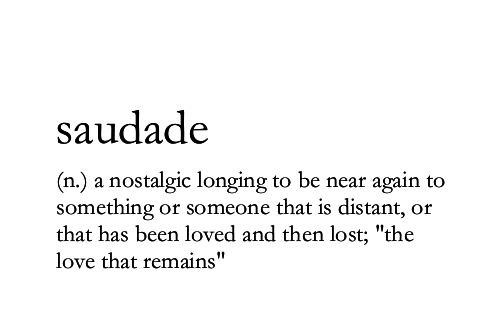
Tutto questo mi procura un fremito, perdo la concentrazione, dannata concentrazione quanto è difficile tenerti a me. Stringo forte gli occhi perché non ho intenzione di aprirli. Voglio rimanere qui, in silenzio. A pochi passi dai miei sogni, e con una mano provare ad afferrarli come ho fatto in passato. Per prenderli però devo tornare a sognare, basterebbero trenta secondi, solo trenta, e sognare finalmente di sorridere a tutte le insonnie trascorse con la testa appoggiata al grembo della rabbia. Ho bisogno di silenzio, non di rassegnazione o chiusura, ma di silenzio, quello che mi aiuta a ridare un peso alle parole, dopo tutte quelle maldestramente vuote, inutili e violente. Come dal virtuosismo nato da un poeta latino antico, sono stato cattivo e prigioniero, perché pervaso dalla tristezza. Ho scaraventato fuori tutto quello che avevo ingoiato in una vita, ho urlato forte sì, volevo cercare di spaventare quei fantasmi che tornavano portando echi antichi di paura e disperazione. Poi però ho taciuto, è vero ho taciuto, quando mi sono accorto che proprio le parole mai proferite sono quelle che raccontano più di noi, perché consegnano quella dimensione di verità da cui non puoi rifuggire, quella che sta tra te e te. Ho cercato di liberarmi da quella prigionia, da quella tristezza, cercando di allontanare il più possibile tutto, ho perso il limite, quel limite che aiuta a distinguere, a riconoscere, ad amare, a esprimere. L’ho perso perché ho incastrato il presente tra i ricordi del passato, quel posto dove vai a cercare conforto quando tutto va per il peggio, ma sai benissimo che conforto non troverai. Quel posto che odora di naftalina, e il presente si sa, non può odorare di naftalina. Sono stato cieco. Con gli occhi chiusi mi procuro ora nuovamente cecità, questa volta però per distinguerla da «quella che mi ha procurato un destino chirurgo» (cit.)
Oggi mi sento così, rotto da questo insieme di altalenanti e incostanti stati d’animo che ancora ringhiano, si picchiano e pisciano uno contro l’altro come cani randagi alle periferie della città per un tozzo di pane, o forse più semplicemente alla ricerca di un ricovero dove potersi addormentare per una notte, senza il timore che qualcuno ti assesti un calcio perché puzzi o gli/le fai cagare.
Ho ancora gli occhi chiusi, mi sembra però di risentire per un attimo il rumore profondo e cupo, il vento sgarbato che mi arriva addosso e la brezza che mi bagna la faccia. Burrascoso, inquieto e a tratti inquietante, ma assolutamente vivo ed in continuo movimento, sento il bisogno della sua vastità per potermi riprendere quel senso di limite che mi ero perso.
Oceano
Apro gli occhi e lo vedo, esattamente lì di fronte a me, lo contemplo. I secondi diventano ore. Ad un tratto d’istinto corro verso la bellezza per agguantarla, prima che il vento la disperda dentro al fragore delle onde:
volti; persone; abbracci; gesti; pratiche-fardello di anni e anni, bruciate nel rogo divampato dentro la mia crescita, giorno dopo giorno; stelle cadenti, guida e fari di cammini lontani e poi… poi quel rumore, quel fottutissimo rumore che puzza di benzina e assenza, ma odora di libertà.
Guardo quello che sto tenendo stretto. Vorrei dire qualcosa, ma tutte le mie parole d’amore sono spesso inciampate nella non conoscenza e nella paura, ho pagato per questo il prezzo della vergogna sottolineata dalle dita puntate verso la mia inadeguatezza.
Non ne ho altre, non ne trovo oggi, per questo rubo, mendico, nel tentativo di conoscere e mi interrogo… l’amore che rimane …
L’amore che rimane allora forse è quel gruccio che mi rendo conto di avere, quello che porto sempre con me, quello che non so ancora bene se sarà la mia più grande condanna, o la mia più grande liberazione.
Cortazar, Julio Cortazar, in una intervista nel 1977, lo espresse dicendo:
«Personalmente continuo ad avvertire
la presenza di qualcosa che si trova dall’altra parte delle cose
e per questo non smetterò mai di cercare»

Sono qui…. Ancora una volta… il tempo degli incontri e dei raduni è finito
Ho tutto stretto a me, il mio gruccio, i miei dubbi e le mie poche certezze, e poi gli incontri, gli amori, i saluti, le lacerazioni, i lutti, gli abbandoni e i sogni. Tutto è qui con me. E’ ora di un altro viaggio e di un altro tempo.
Un tempo senza lancette, minuti o ore, un tempo-non-tempo che prende il nome di elaborazione. C’è un viaggio, o forse più, una nave che mi aspetta la cui rotta per ora è una: Venezia… ma poi chissà…
Outra Vez… saudade…